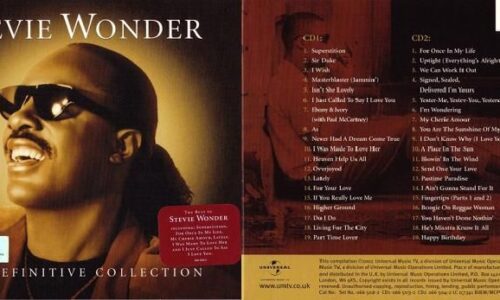La varietà di stili e la tendenza alla contaminazione musicale che vide negli anni ottanta alcune delle sue forme d’arte più elevate, trovò forse la sua punta di diamante in quella commistione di musica popolare e tradizionale, sia folk che etnica, che prese il nome non proprio fantasioso di world music. In origine, il termine veniva utilizzato semplicemente per raggruppare tutte quelle sonorità che non facevano parte della cultura musicale occidentale ed erano relegate sostanzialmente all’ambito accademico, in particolare quello antropologico. In seguito, soprattutto a partire dagli anni sessanta e grazie agli enormi flussi migratori di popoli provenienti dai vari paesi del terzo mondo, tutti questi suoni iniziarono a diventare familiari per il mondo civilizzato, anche grazie ai mezzi radio-televisivi presenti soprattutto nelle grandi metropoli. Fu però solo nel corso degli anni ottanta che le musiche provenienti da queste culture iniziarono a diffondersi su larga scala, grazie soprattutto a due grossi fattori che ne prepararono la strada: il successo planetario della musica reggae, veicolata da personaggi come Bob Marley e Jimmy Cliff e la fondazione da parte di alcuni artisti di fama mondiale di etichette finalizzate alla creazione e alla distribuzione su larga scala della musica etnica. Queste variabili e il momento storico propizio fecero sì che la musica popolare occidentale finisse in qualche modo per fondersi con quella cultura millenaria così ricca di suoni non ancora abusati, creando di fatto quelle mescolanze che determinarono la nascita di un vero e proprio genere. Anche se in epoca non sospetta artisti come Jimmy Page e Robert Plant avevano palesato la propria passione e ammesso pubblicamente il fascino suscitato in loro da certe sonorità nordafricane, tra i primi a capire che quel mondo poteva essere fonte d’ispirazione infinita fu l’ex Genesis Peter Gabriel. Se già come leader del celebre gruppo progressive, Gabriel si era distinto per la creazione di un art rock visionario e per una curiosità intellettuale che pareva senza limiti, anche da solista la voglia di sperimentare non venne meno, ma si spostò semplicemente in altre direzioni. Nel corso del decennio che andava dalla fine dei seventies alla seconda metà degli anni ottanta, tutto il percorso artistico di Gabriel può essere inteso come un lento avvicinarsi alla realizzazione della totale integrazione tra world music ed elettronica. Se già i primi tre album solisti ne avevano mostrato la voglia di aprire i propri orizzonti musicali a sonorità esotiche, e il posteriore So rimarrà per sempre il suo best seller, il culmine della commistione tra generi da lui tanto agognata avvenne con due album in particolare: IV (Security) e Passion, colonna sonora realizzata per il film L’Ultima Tentazione di Cristo di Martin Scorsese. L’utilizzo di una strumentazione etnica variegata e senza precedenti aveva già iniziato ad essere presente sul terzo album, così come la presenza massiccia di tematiche legate all’ambito sociale e politico di quegli stessi paesi da cui Gabriel attingeva ispirazione a livello musicale. Fu però solo con IV e la quasi contemporanea istituzione del festival Womad (World Of Music And Dance), nato per celebrare la musica, l’arte e la danza di ogni angolo del mondo che la visione musicale di Gabriel, fino ad allora perfettamente compiuta solo nella sua mente, divenne concreta. Il quarto album della sua carriera fu infatti il primo a mostrare un equilibrio perfetto tra i suoi sforzi attivistici concreti, da anni era impegnato in una campagna sociopolitica di sostegno alle popolazioni meno fortunate, la sua tenacia nel cercare sempre strade nuove e pionieristiche e la promozione della diversità attraverso la musica. Sempre più convinto che l’arte non servisse a riprodurre semplicemente ciò che tutti vedevano con i propri occhi, ma che avesse il ruolo più ambizioso di rendere visibile ciò che non lo era e galvanizzato dalla risposta sempre più entusiastica alle proprie sperimentazioni, Gabriel raduna una serie di musicisti provenienti da paesi asiatici e africani (tra i quali Shankar e la futura star mondiale Yossou N’Dour) e dà vita a Passion, forse il punto più alto del suo percorso all’interno della “musica di tutto il mondo”. Culture così diverse come quelle di Pakistan, Turchia, Egitto e Nuova Guinea finiscono così per confluire in un lavoro che segnerà tanto i musicisti coinvolti che lo stesso Gabriel, qui nel ruolo di grande orchestratore e deus ex machina del progetto. Incredibile e assolutamente inedito fu poi il lavoro fatto a livello spirituale dall’opera, che nacque e si sviluppò per prima cosa come grande tentativo di unione tra religioni e modalità di pensiero spesso agli antipodi tra loro. L’esempio più lampante del lavoro fatto da Gabriel nel suo percorso personale e artistico è forse il brano che dà il titolo all’opera, con il canto muezzin di Gabriel che si fonde a quello del pakistano Nusrat Fateh e ai vocalizzi di Youssou N’Dour. Da lì a pochi anni Gabriel sentirà l’esigenza di creare una propria etichetta, la Real World Records, con la quale contribuire a rendere noti al grande pubblico artisti provenienti da ogni angolo del pianeta, con una particolare attenzione per quelli del Terzo Mondo.
Un percorso per certi versi simile a quello di Peter Gabriel, anche se maturato in circostanze differenti è quello di Paul Simon. Da sempre affascinato dall’unione di generi differenti, anche se incline in egual modo al folk più malinconico e sentimentale, l’ex compagno di Art Garfunkel impiega qualche anno prima di capire quale sia la vera strada da seguire. Dopo tre album figli legittimi del lavoro svolto con l’ex compagno, ma dove già avevano fatto capolino sonorità meno convenzionali come reggae e jive, e il fallimento completo di Heart And Bones, Simon, con le spalle al muro, crea il classico album in grado di definire un’intera carriera: Graceland. Messa in piedi una vera e propria superband che vedeva tra le proprie fila gli idoli Everly Brothers, l’amica Linda Ronstadt e un ensemble composto da alcuni dei migliori musicisti sudafricani, Paul Simon creò un vero e proprio manifesto sonoro e lirico in grado di competere alla pari con la poetica “equo solidale” di Peter Gabriel. Le tematiche umanitarie, mai affrontate prima in questo modo e scevre dalle ambiguità del contemporaneo Live Aid, i temi della compassione e del rispetto affrontati senza un briciolo di retorica e populismo, uniti ad una ricerca sonora maniacale e atta a rendere visibile alla massa un mondo sotterraneo non ancora svelato, fecero di Graceland un vero e proprio manifesto politico ancor prima che artistico. Paradossalmente, in un’epoca segnata da forti conflitti sociopolitici, anche un disco impossibile da fraintendere come Graceland finì per subire l’ira del movimento anti apartheid, che in modo ottuso e per puro partito preso accusò Simon di aver rotto l’embargo che la comunità artistica e culturale aveva indetto nei confronti del Sud Africa. Una sterile polemica che non impedirà al disco di rimanere una pietra miliare in grado di affascinare generazioni di musicisti.
Terzo vertice dell’ideale triangolo world music del decennio non può che essere l’ex Talking Heads David Byrne: anche lui, dopo lo scioglimento della band d’origine e grazie anche al visionario compagno Brian Eno, spinse infatti le coordinate della propria creatività verso suoni e visioni tanto alienati quanto innovativi e precursori di decine di album a venire. Chi, nel 1981, mise sulla puntina del proprio stereo My Life In The Bush Of Ghosts non si trovò semplicemente ad ascoltare il primo album composto a quattro mani da due delle maggiori menti creative del music business, ma ad aprirsi una vera e propria porta sul futuro della sperimentazione sonora e la contaminazione tra generi. Un melting pot di sonorità in cui per la prima volta elettronica e spiritualità, musiche di paesi lontani e preghiere del corano convivevano in canzoni dal sapore afro come Help Me, The Carrier, arabeggiante e trip hop vent’anni prima del Bristol Sound o ancora Regiment, segnata dal canto libanese di Dunya Yusin e precorritrice del novanta per cento dei brani etno degli anni successivi. Anche se i successivi The Catherine Wheel, colonna sonora per il balletto della coreografa Twyla Tharp ispirato dalla figura di Santa Caterina da Siena e Music For The Knee Plays, scritto per l’opera di Robert Wilson The Civil Wars, sembrano andare in direzioni diverse da quelle della world music tout court, con Rei Momo Byrne raggiunge uno degli apici assoluti di un intero genere: non pago di quanto sperimentato fino ad allora e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, l’ex Talking Heads trovò quello che cercava in America Latina, per la precisione in Brasile e quello che ne scaturì fu un album dai suoni gioiosi, figli di una cultura lontana anni luce dalla sua Scozia e vero porto di mare delle sonorità più disparate: merengue e salsa, ma anche cha cha e mambo si trovarono così a fondersi in un opera dedicata ad una delle figure pagane più amate dai brasiliani: il dio del Carnevale carioca. L’entusiasmo fu così elevato da spingere l’artista a fondare un anno prima di Peter Gabriel la propria etichetta che producesse world music, la Luaka Bop, dimostrando ancora una volta di essere un vero e proprio prodromo e un faro costante per pubblico e colleghi. Col tempo, il termine world music finì per indicare tanto la musica creata da musicisti occidentali contaminata da altri mondi, quanto quella di artisti africani, sudamericani e asiatici scoperti e prodotti da etichette nate con quello scopo e che generalmente seguivano la via inversa: partendo dalle proprie tradizioni musicali e adattandole al pubblico europeo e americano. A dimostrazione che probabilmente il primo esempio di globalizzazione nacque proprio da qui.