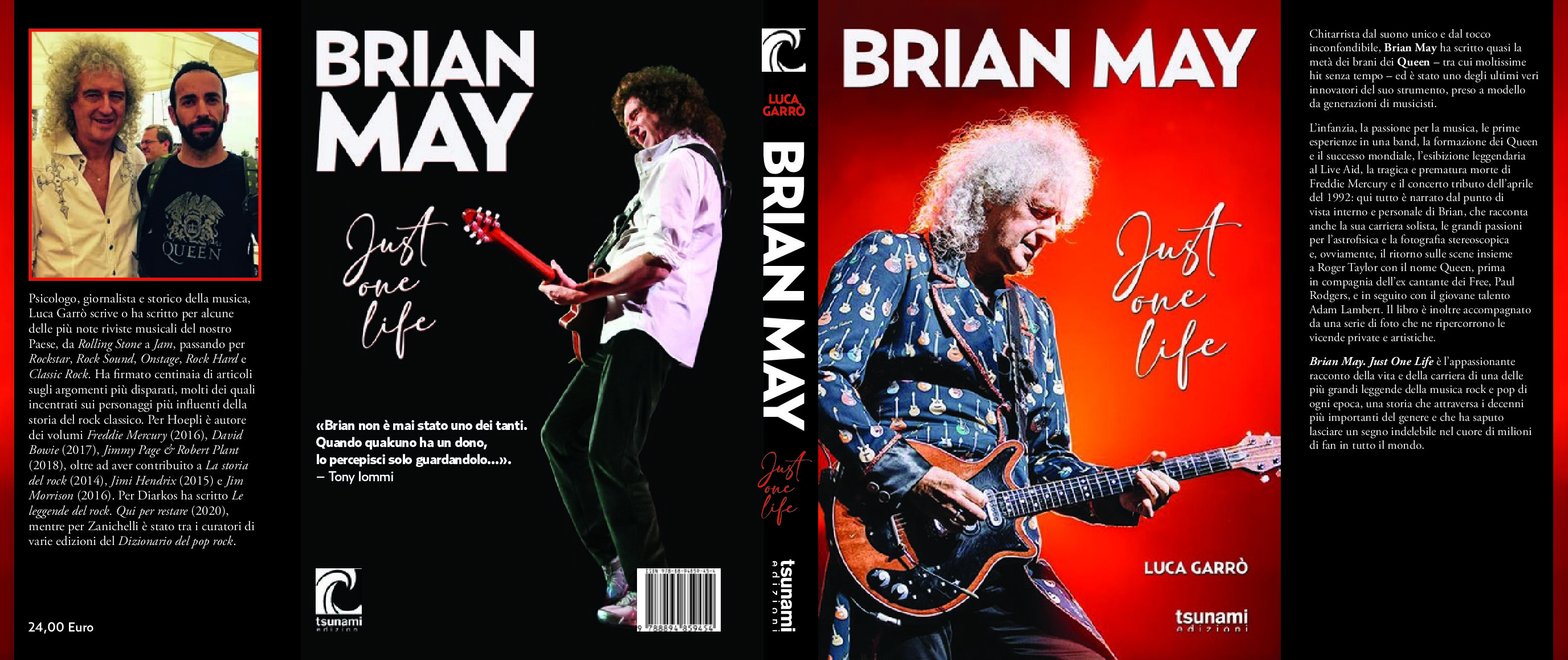Brian May non ama parlare del suo passato con i Queen: troppe le emozioni, spesso dolorose, che certi ricordi si portano dietro. Certe ricorrenze, tuttavia, non possono essere ignorate. È il caso del quarantesimo anniversario di Bohemian Rhapsody, forse la canzone più celebre degli anni settanta, per molti anche più di Starway To Heaven dei Led Zeppelin e Imagine di John Lennon.
La band che, esattamente quarant’anni fa, si accingeva a pubblicare uno dei brani (e degli album) che avrebbero cambiato per sempre la storia della musica popolare, non era assolutamente quell’icona indiscussa che chiunque, in qualunque parte del mondo, oggi è abituato a considerare i Queen. All’inizio del 1975, infatti, la situazione del gruppo di Freddie Mercury e compagni non era delle più rosee e, anche se il successo del precedente Sheer Heart Attack aveva riportato un po’ di ottimismo tra i musicisti, le nubi erano ancora ben visibili sopra le loro teste. “Eravamo alla ricerca di un segnale che ci dicesse che stavamo andando nella direzione giusta e il successo ottenuto da Killer Queen rappresentò un po’ il giro di boa” – ricorda Brian May – “Fino al mese prima eravamo comunque ancora degli squattrinati e sostanzialmente degli sconosciuti, come la maggior parte delle band come noi in lotta per emergere, ma da quella piccola fiamma credo abbia iniziato a nascere A Night At The Opera. Credo che al giorno d’oggi non saremmo mai riusciti a trovare qualcuno disposto a finanziarci oltre il secondo disco, quindi probabilmente ANATO non avrebbe mai visto la luce”. Uno degli ostacoli verso la definitiva consacrazione risiedeva tuttavia proprio nella Trident, l’etichetta che gli aveva sì permesso di pubblicare i primi album, ma che allo stesso tempo li aveva privati di quasi ogni diritto: “Sostanzialmente erano dei poco di buono. Noi eravamo inesperti e con una grande bisogno di farci conoscere, ma quando ci rendemmo conto che con quel contratto non avremmo mai guadagnato nulla dalla nostra musica, iniziammo una lunga battaglia per il possesso del nostro catalogo”. Vinta la prima battaglia ed essendo riusciti a mantenere nel proprio entourage il produttore Roy Thomas Baker, che li aveva aiutati ad ottenere proprio quel primo contratto, i Queen poterono così tornare in studio per dare vita al quarto album della loro carriera. “A differenza del passato, quella fu la prima volta in cui entrammo in studio senza avere minimamente idea di quello che avremmo creato. Non avevamo nessun brano pronto, se non alcuni spunti della mia The Prophets Song, che ironia della sorte sarebbe stata l’ultima canzone ad essere terminata per l’album (e quella che sarebbe passata alla storia se non fosse esistita Bohemian Rhapsody, ndr)”. In realtà, ognuno dei quattro componenti della band aveva qualche idea per la testa, ma si trattava per lo più di suggestioni: l’unica cosa che li accomunava era la voglia di superare i propri limiti, di spingersi oltre le proprie possibilità. La cosa dovette sembrare immediatamente chiara proprio a Baker, che un pomeriggio a casa di Mercury assistette ad una performance che avrebbe cambiato per sempre il concetto di musica pop. “Quel pomeriggio Freddie si mise al piano – ricorda ancora May – e con grande disinvoltura fece sentire questa sorta di ballata pianistica al nostro produttore, che rimase immediatamente colpito dalla melodia dell’introduzione. Il testo non era ancora completato, dunque Freddie spesso vi aggiungeva dei suoni che sarebbero diventati il testo drammatico e criptico che tutti conosciamo. Il momento in cui si fermò, comunicando al produttore che in quel momento sarebbe partita la parte operistica, ormai fa parte della storia”. Per la band stare in studio non era mai stato semplice e, sostanzialmente, non lo sarebbe stato per tutto l’arco della carriera, ma dagli scontri e dalle tensioni che caratterizzavano le sessioni di registrazione, spesso erano nate le cose più belle composte dai quattro. Tuttavia, Bohemian Rhapsody fu subito una storia a sé: “Si è sempre trattata di una creatura di Freddie, già nel momento in cui la faceva ascoltare a Baker nel salotto di casa sua sapeva perfettamente come sarebbe stato ogni secondo di quei sei minuti. Inizialmente non credemmo facesse sul serio, ma in realtà aveva una visione musicale ben precisa fin dall’inizio e per certi versi la registrazione del brano fu molto semplice, con il solco di accompagnamento composto solo da piano, basso e batteria. Furono tutti quei Galileo a complicare un po’ il lavoro…”. Il clima in studio, già di per sé molto vivo, subì un’impennata decisa al momento della registrazione del brano. Le idee nascevano in continuazione e la voglia di sperimentare, aspetto che ai tempi accomunava i quattro, portava ognuno a provare soluzioni inedite, sempre con l’autoimposto divieto di utilizzare sintetizzatori. “Fino a The Game, dove non arrivano i sintetizzatori, arrivava la mia chitarra. Da questo punto di vista, A Night At The Opera resta uno dei momenti in cui sono riuscito ad espandere maggiormente i confini del mio stile chitarristico. La cosa straordinaria dei brani di Freddie e di Rhapsody in particolare, era che riuscivano ad ispirare i miei assoli in un modo che i pezzi che componevo personalmente non riuscivano a fare. È qualcosa di difficile da spiegare, ma mentre ascoltavo quell’opera d’arte prendere forma, in modo completamente naturale nascevano gli assoli nella mia testa”. Il pezzo, ad ogni modo, non nacque per caso: Freddie da tempo compiva ricerche su brani operistici, anche se apparentemente con l’intento di ricavarne qualcosa di ironico piuttosto che quella che, venticinque anni dopo, sarebbe stata definita la canzone del millennio. “Col tempo ho pensato che ci fossero delle analogie tra il suo avvicinamento all’opera di quel periodo e quello simile che ebbe nei confronti del walzer poco tempo più tardi, da cui poi prese vita un altro dei suoi pezzi che amo di più, The Millionaire Waltz contenuta in A Day The Races. C’era sempre uno spirito burlesco che ne animava certe composizioni e la cosa geniale è che riusciva sempre a trasformarlo in arte”. Se A Night At The Opera per anni rimase l’album più costoso della storia, molto lo si deve proprio alla traccia che ne decretò il successo: tre settimane e diversi studi di registrazione per mettere su nastro un solo brano restano ancora oggi qualcosa di assolutamente folle. Il procedimento di registrazione, poi, toccò vertici mai raggiunti prima e incontrò difficoltà dovute al fatto che le idee di Mercury, paradossalmente, andavano oltre le possibilità offerte dalla tecnologia dell’epoca: “Eravamo perfettamente coscienti di stare creando qualcosa di epocale, qualcosa di simile a Sgt. Pepper dei Beatles o roba di quello spessore. Il problema più grande era legato alla dissolvenza dei nastri: facemmo girare così tanto quello di Boh Rhap che a un certo punto ci accorgemmo che lo stavamo cancellando. Il rischio era quello di perdere la musica per cui avevamo fatto tutto quel lavoro. Inoltre le piste erano sì maggiori rispetto a qualche anno prima, ma di certo ancora non infinite e quella registrazione folle ne esigeva una quantità notevole. Ogni volta che Freddie aggiungeva qualcosa, altro andava inevitabilmente a perdersi”. I quasi sei minuti di brano che ne nacquero furono la conferma del fatto che la stampa inglese fino a quel momento avesse sbagliato clamorosamente a definire i Queen una copia sbiadita dei Led Zeppelin e Freddie un eccentrico cantante glam: “Mi è capitato spesso di parlarne con Roger negli anni. La cosa che più ci dà fastidio di tutto il parlare di Freddie è quel continuo puntare il dito sul fatto che fosse un grande performer, un intrattenitore e cose di questo tipo. Verissimo, ma si tende a sottovalutare che razza di artista e di musicista fosse. Non si trattava solo di gorgheggiare insieme al pubblico o dare spettacolo su un palco e credo che Bohemian Rhapsody sia lì a dimostrarlo ormai da quarant’anni”. A completare quell’opera di rivoluzione di ogni canone musicale fino ad allora esistente, giunse infine il primo video promozionale mai realizzato da un gruppo rock, creato in sole quattro ore per sopperire all’impossibilità di partecipare al celebre programma Top Of The Pops: “Una serie di congiunzioni astrali (e detto dall’astrofisico Brian May fa alquanto sorridere, ndr) fece sì che entrammo nella storia più di una volta con la stessa canzone. Lo girammo così in fretta che nemmeno avemmo il tempo di poterlo rivedere prima della messa in onda nel corso della trasmissione. Il clamore suscitato dal video ci spinse a proseguire lungo quella strada, ma onestamente senza mai riuscire ad eguagliarne il fascino e la naturalezza”.