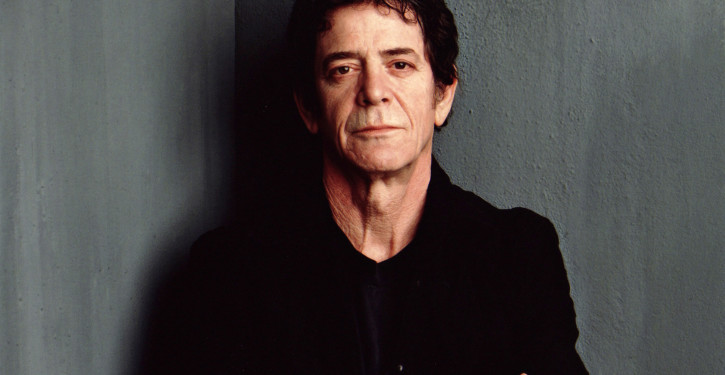Le recenti dichiarazioni di Laurie Anderson, secondo cui David Bowie, all’uscita di Lulu, si espose a tal punto da definirlo uno dei grandi capolavori dell’amico di una vita, hanno riaperto un acceso dibattito circa l’ultima pubblicazione ufficiale di Lou Reed prima della scomparsa. “Non preoccuparti se nessuno lo capirà, verrà rivalutato nel tempo come molti suoi capolavori. La gente non è in grado di capirlo in questo momento” – pare siano state le parole del Duca Bianco, che ancora oggi considera l’album con i Metallica uno dei vertici assoluti dell’ex Velvet Underground. Che siate o meno d’accordo con Bowie, è evidente che il termine eclettismo abbia sempre assunto un significato molto particolare quando lo si utilizzava per parlare della carriera artistica di Lou Reed, da sempre caratterizzata da mutamenti (sia estetici che prettamente musicali), nonché costellata da mille contraddizioni o presunte tali. Se, infatti, partiamo dagli esordi newyorkesi con i Velvet Underground per giungere all’ultima “follia” dell’album insieme ai Metallica, quello che ci troviamo di fronte è un percorso apparentemente schizofrenico, impossibile da decifrare se non attraverso un attento lavoro che consideri le sofferenze interiori di Reed come il fuoco centrale di tutta la sua opera.
“So imitare Lou Reed meglio di chiunque altro. Guardate: mi sto trasformando in Lou Reed proprio sotto i vostri occhi”: basterebbero queste parole, che suonano quasi come una confessione, per capire i tormenti di un artista che ha saputo mettere una carica emotiva così forte nei propri brani da risultargli spesso persino difficile suonarli, tanto era il dolore che gli provocano. Non stupiscono, in questo senso, le dichiarazioni di Kirk Hammett quando ammise candidamente di “aver pianto di fronte ai testi di “Lulu”, né quelle di tutti coloro che confessano la propria fatica di fronte a testi così carichi di disperazione.
La sensazione è che ogni volta in cui Lou abbia parlato di emarginati, reietti, di eroinomani e di trans gender, il protagonista fosse sempre lui, quasi come se la musica, i suoi testi così allucinati e spesso taglienti potessero avere un effetto catartico simile a quello di una vera e propria terapia. In alcuni casi i riferimenti alla propria persona non sono stati nemmeno velati: un brano come Kill Your Sons, in cui Reed parla della terribile esperienza dell’elettroshock, mette i brividi ancora oggi, tanto era l’odio riversato nei confronti dei propri genitori, incapaci di accettare le sue peculiarità, così come verso quegli “psichiatri senza cuore” che cercavano di cambiargli barbaramente personalità. Non serve uno psicologo per leggere tra le righe lo specchio fedele di una vita caratterizzata da disturbi psichici molto marcati, probabilmente solo incrementati da quello che un tempo gli psichiatri consideravano la panacea di tutti i mali e ampliato dal successivo abuso d’alcol e droghe pesanti. Persino la sprezzante superbia di frasi come “una mia settimana vale un vostro anno” o altre spacconate di quel tipo, probabilmente servivano a Lou per mascherare incubi inconfessabili, cercando allo stesso tempo di dare un’idea di sé migliore di quella che con cui si trovava a convivere da sempre. Anche la spettacolarizzazione stessa della dipendenza, messa in mostra col buco in diretta durante l’esecuzione di Heroin, rientra perfettamente nel discorso e, ad un occhio attento, non può che apparire per quello che è: una richiesta d’aiuto, fatta a coloro con cui si sentiva più libero di esprimersi: i propri fan. Non una banale apologia degli stravizi e della vita d’artista dunque , ma il segnale evidente di un disagio incapace di rimanere ancora nascosto.
E’ però l’intera discografia di Reed a sembrare un trattato di psicologia, a partire da Berlin, frutto deviato della fine del suo primo matrimonio e così crudo e violento da renderne difficile l’ascolto completo in una sola sessione persino al suo stesso autore per diversi anni. Per non parlare del celeberrimo Metal Music Machine, folle trasposizione artistica dell’esaurimento nervoso che lo aveva colto alla metà degli anni settanta; per non parlare di quello che, ancora oggi, pare uno dei casi più emblematici di disagio psichico mai messo in atto in una canzone, Gimme Some Good Times. Opener di Street Hassle, album del 1978 che nella title track vede la partecipazione non accreditata di Bruce Springsteen, il brano mostra Reed cantare mentre in sottofondo un’altra delle sue personalità distrugge Sweet Jane: poco più di tre minuti di delirio, in cui l’autore sembra lottare contro il proprio vecchio io, facendo a pezzi il suo maggior successo e prendendosi gioco di se stesso senza un briciolo di ironia. Il vero fulcro della sua poetica resta tuttavia la sessualità, da sempre causa dei maggiori disagi interiori. Dal disgusto provato dai suoi genitori alla parola “bisessuale”, passando per la sua lunga relazione con un transessuale e due matrimoni, di cui quello con Laurie Anderson durato fino alla fine dei suoi giorni, è evidente come egli non sia mai riuscito completamente ad esprimere appieno se stesso, trasportando poi tutto il malessere nell’unico modo che conosceva, mettendolo in musica. Chissà che i Metallica, reduci dei tormenti narrati in Some Kind Of Monster, non abbiano rappresentato una buona spalla a cui appoggiarsi per il vecchio Lou…